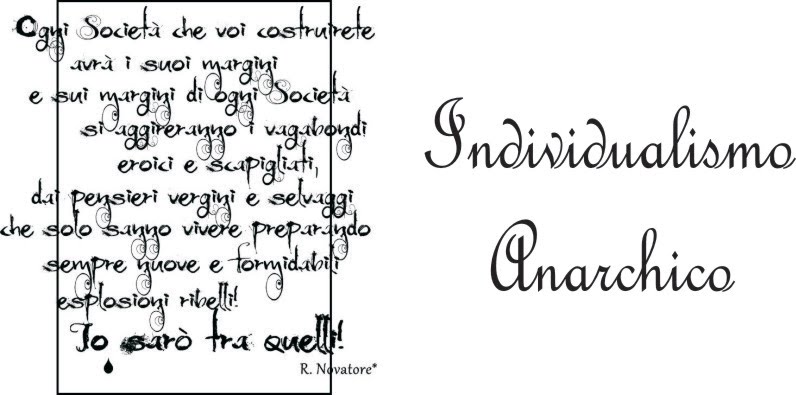A mo’ di premessa
«Cosa hanno dunque di così strano, quasi fuor di luogo, queste luci a cui non chiedo di significare nulla? È la loro irregolarità, la loro instabilità, la loro lucentezza ora forte ora debole, ma che non supera mai la potenza di una o due candele?, [...] dirò da ora in poi, per maggior sicurezza, che attendo molti di questi lumi, come d'altra parte tutti gli elementi analoghi di simile incertezza, per aiutarmi a continuare ed eventualmente a concludere.»
L'esistenza come «volontà di potenza».
Tra luci e ombre che accompagnano l'esistenza di ognuno, il nostro vivere quotidiano non può prescindere dall'interpretazione che ne diamo, in quanto è fuori dubbio che, solo a partire dall'interpretare la realtà e le circostanze che questa ci pone di fronte, noi interpretiamo noi stessi. Implicita o esplicita ogni cosa che sosteniamo è – bene o male – una nostra interpretazione soggettiva.
Nel nostro continuum esistenziale il movente che incessantemente ci costringe a “metterci in chiaro” rispetto alla situazione di ambiguità in cui vorremmo permanere immersi, riguardo a noi stessi, ci proviene da quello scorgersi continuamente tesi a oscillare tra il far atto di mera presenza, tramite quel “eccomi qua” che accompagna ogni giustificazione, e quel passare dallo sconforto più cupo, per essersi scorti vacillanti e insicuri nel profondo di sé, alla sfida aperta e violenta rivolta a se stessi nel voler emergere a tutti i costi. Per cui finiamo sempre per non poter mai limitarci a vivere e basta, a non poter mai essere, insomma, degli uno qualsiasi tra i molteplici esseri viventi che abitano il mondo di cui facciamo parte. Il bisogno ineludibile che proviamo, o sentiamo, nel voler conferire senso a se stessi, alle cose che facciamo e a tutto ciò che ci circonda, è dato dalla situazione di crisi-conflitto descritta poc'anzi.
La volontà di emergere è alla radice di ogni nostra più propria espressione e l'arte, la poesia, la musica, il “sapere”, fino all'indiscussa necessità e capacità di comunicare, sono i nostri più propri sensi intenzionali.
Il voler emergere è la nostra volontà di esistere e di vivere, che si oppone con tutte le sue forze all'annientamento che scaturisce dal rigore mortale del nulla. Vivere è, in sostanza, illudersi evitando la conoscenza annientante della propria nullità, in quanto l'esistere è appunto illusione di non essere nulla.
Nessuno può fare a meno delle illusioni finché vive, in quanto sono il suo rimedio alla disperazione che ci assale di fronte all'assoluto nulla che grava su tutto, compresi se stessi. Sono queste «cieche speranze» a darci la sensazione di vincere la morte e a renderci così sopportabile e piacevole la vita, di fronte a quel «misero e freddo vero», alla «verità dura e triste», che «tutto è nulla» – come mirabilmente evidenzia nei suoi scritti Giacomo Leopardi, anticipando così la tematica nietzscheana legata a quel dover prendere atto che «c'è un solo mondo, ed è falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza senso [...]. Un mondo così fatto è il vero mondo [...]. Noi abbiamo bisogno della menzogna per vincere questa verità, cioè vivere.» –.
Inoltre, è sempre Giacomo Leopardi, in questa prospettiva di rovesciamento legata al bisogno di menzogna, ad evidenziare lucidamente che la colpa di Adamo è stata quella di aver voluto conoscere e non certo di aver voluto vivere, come dopo di lui è andato sostenendo A. Schopenhauer, il quale, per questo suo particolare punto di vista esistenziale, guarda all'arte e alla poesia come ad espressioni della negazione della volontà di vivere; quando, invece, queste ne sono la sua forma più alta e potente, fino a costruirne «un suo quasi rifugio» – come acutamente sostiene Emanuele Severino nel suo saggio Il nulla e la poesia inerente l'opera filosofica e poetica di Giacomo Leopardi –.
Ogni esistenza vuole se stessa con tutte le sue forze, sempre e comunque, al di là di tutto, in quanto espressione del proprio «amore di sé», o se si vuole, come «puro egoismo» e nessuna cosa può distoglierla dalla sua «volontà di potenza», che è illusione che produce illusione e come tale si allontana e nel contempo si solleva al di sopra del nudo e crudo nulla.
Il nulla è l'annientamento di ogni cosa, è la morte di tutto, come pure l'essere inconoscibile di ogni cosa, ma è anche il fatto della vita. Anzi, è il solo fatto della vita, essendo tutto ciò che ci permette di conferirgli senso. Perché senza la morte non avrebbe senso parlare di vivere. E poi che senso avrebbe il successo o il fallimento, l'amore o l'odio, se non gravasse su di noi il nulla? Quel nulla assoluto, che per noi mortali è tutto e a rivelarcelo, indiscutibilmente, è la nostra inestirpabile voglia ... voglia di esistere e di vivere, o se preferite, «volontà di illusione» o di «potenza».
«Tutto è nulla» compreso il dolore, perché, come sostiene Leopardi, anche il dolore passa come ogni altra cosa e l'essere di ogni cosa, compresi se stessi, si fonda su di un «solido nulla». Tutto ciò che esiste è impossibilitato a salvarsi dal nulla che l'accompagna e gli sovviene, fino a giungere a disperderlo o inghiottirlo per farlo rientrare dentro di sé. Per cui, se non si «vuole perire a causa della verità» – come sostiene F. Nietzsche –, è bene riconoscere con se stessi che gli errori e le illusioni sono le condizioni indispensabili per poter vivere e per poter continuare a farlo.
La crisi come presa di coscienza del nostro esistere
Per comprendere la validità di quanto finora esposto, ciascuno passi in rassegna i momenti e gli incontri più importanti avvenuti nella sua vita fin'ora, comparandoli tra loro uno per uno; riceverà l'impressione che l'intensità e il coinvolgimento maggiore di se stesso era esclusivamente nell'insieme di illusioni che alimentavano i suoi desideri in tali circostanze. Ebbene, tutto questo diviene un'inezia paragonato a quel che si prova di fronte al venir meno, dentro di sé, delle proprie illusioni, quindi al venir meno del proprio vivere.
Quando si entra in questa situazione con se stessi non vi sono pianti, né emozioni, né trasalimenti metafisici di alcuna specie, a confortarci nel prendere atto, con indicibile dolore, che il mondo vero, così com'è, non è fatto per intrattenere quel sogno umano, perché, nel folle divenire di sé, ciò che cela, come fondo di tutto, è delirio, caso, indifferenza, riguardo proprio ogni vicenda che vi accade. Ogni cosa che vi accade, accade senza un perché, e ciò che accade può pure non più accadere e succedergli dell'altro, per cui non esiste alcun principio che possa trascendere le cose, vale a dire non si può giudicare alcuna cosa prima che questa stessa cosa non appaia sulla scena del mondo, insomma, che abbia preso ad esistere sporgendosi provvisoriamente dal nulla da cui è scaturita. E il suo realizzarsi è tutto, per potervi rientrare. Poteva pure non accadere, poiché non vi è nulla di necessitante a questo mondo che non siano le nostre stesse illusioni alimentate su di esso. Per cui nessuno può mai «giudicare le cose innanzi alle cose», senza cioè, nel farlo, compiere un atto di disonestà intellettuale nei confronti di se medesimo prima ancora che con gli altri.
Tutto ciò che esiste è finito, in quanto tutte le cose che esistono hanno avuto un loro inizio e così avranno pure una loro fine, cioè hanno una loro precisa durata. L'esistere di una qualsiasi cosa non è concepibile al di fuori di un prima e di un dopo che ci porta a scorgerla come tempo della sua stessa durata, che è nient'altro che il tempo che trascorre conservandosi rispetto a quanto, inesorabilmente e irreversibilmente, va disgregandola; vale a dire si consuma perché questo è proprio dell'esistere di ogni cosa.
L'eternità e l'infinito non possiamo, per le ragioni appena esposte, ritenerle delle cose, proprio perché non contengono una loro fine, per cui non hanno mai cominciato ad esistere, cioè non sono nemmeno mai nati. Ciò vuol dire che sono pure illusioni prodotte dalla nostra volontà di potenza, che volendo se stessa illudersi oltre ogni limite, alimenta il proprio desiderio infinito di esistere eternandosi. L'arte, la poesia, la musica e il “sapere” stesso, sono l'espressione più alta di questa sua mirabile illusione.
La ragione, volendo essere misura di ogni concretezza, diviene essa stessa concretezza e questa sua concretezza consiste nel mostrare che tutto ciò che esiste si può misurare, stimare, pensare, constatare, quindi mira a mostrare la finitezza racchiusa in ogni cosa che esiste, quindi la loro stessa fine; per cui più che salvare la nostra volontà di potenza, da cui è scaturita, come vera e propria «lucida follia» dell'esistere, l'annichilisce e, compiendo questa stessa operazione, ricaccia indietro di sé tutte le possibili altre visioni del mondo.
Pensare è, soprattutto, pensare che tutto ciò che esiste è transitorio, cioè impossibilitato a salvarsi dal nulla; quindi, se «tutto è nulla», la verità è quanto di più ostile vi è contro la fascinosa maschera della vita: la nostra volontà di potenza.
Ecco perché a un dato punto della nostra vita, sul venir meno delle illusioni fino a quel momento alimentate, scorgiamo anche nel contempo come inadeguate tutte le risposte dateci fino ad allora; e ciò ci mette in crisi, proprio perché dentro di noi va configurandosi un conflitto tra noi e le circostanze, che supera di gran lunga quello passato, in quanto è ciò che ci ha portato a perderle, ed è qui che emerge in noi l'essere della crisi sopraggiunta in noi.
Tutto questo scaturisce dall'impotenza che si prova quando non si riesce più a riconoscere e controllare, a proprio vantaggio, la realtà in cui si vive; e questo è sintomo lacerante di uno stato di agitazione e di insicurezza, che alimenta il fondo inconscio delle nostre più proprie e inconfessate paure di fronte ad un pericolo da cui occorre difendersi, come nel caso dell'ambiente esterno percepito ostile ed estraneo a se stessi.
Questo processo-conflitto insorto tra noi e le circostanze createsi al nostro immediato esterno, nel suo procedere, lo interiorizziamo nel più profondo del nostro stesso essere, fino a scorgere con orrore, dentro di sé, il «vuoto» e l'assenza di un proprio luogo, dove «dimorare»; ciò è causa di ogni più nostra e propria «vertiginosa» angoscia esistenziale.
Ognuno di noi, venendo al mondo, si trova gettato, nel mare dell'essere, casualmente nel mondo, e il prendere atto del «nulla» o del «vuoto» che alberga nel profondo del nostro essere, alimenta, nel nostro stesso esistere, quell'angoscia originaria indicata da Kierkegaard e da Heidegger.
Il dolore è proprio del nostro esistere, in quanto vorremmo in quel momento tutto cessasse, e il non cessare di una cosa è il suo stesso esistere.
È nella disperazione che apprendiamo che ognuno di noi appartiene al tempo in cui è, come pure che si può disporre di sé e delle cose che ci circondano unicamente per la durata del tempo limitato alla nostra medesima esistenza. Ogni cosa avanti o indietro al nostro tempo, non potendola materialmente possedere non ci appartiene. Sul passato come sul futuro regna lo stesso silenzio, come non può riguardarci affatto nessun avvenimento, per quanto importante possa essere, dopo la morte, perché, tornati al nulla, non essendo quindi più presenti a noi stessi, non ne avremmo percezione. Lo stesso dicasi per gli avvenimenti del passato, i quali rientrati nel nulla da cui si erano momentaneamente sporti per il tempo inerente la loro propria esistenza, noi su di loro non possediamo materialmente più alcun potere reale di modificazione.
È nella crisi, come presa di coscienza del nostro esistere, che tutto è nella transizione di tutto – compresi se stessi. Per cui ogni cosa ci appare caduca ed effimera, e il rapporto tra noi e le circostanze di questo mondo sembra risolversi, comunque sia, nel nostro totale annientamento ad opera di quest'ultimo. È in questo processo di nullificazione di sé e di tutto, nel contempo, che acquisiamo la scettica esperienza di come «vanno le cose al mondo».
Lo scetticismo è ciò che consente l'esercizio del sospetto su tutto, quindi implica sempre lo smascheramento delle imposture contenute negli ideali, i quali, per quanto belli e meravigliosi ci appaiano, comportano sempre il sacrificio della propria vita reale, perché si cessa di vivere e di divenire come si è, a favore di quello che questi prospettano: farci prigionieri come meta di una vita trascorsa nel tentativo di realizzarli. In fin dei conti, uniformandoci ai loro precetti morali finiremmo col perdere noi stessi, in quanto saremmo sempre altro da quel che siamo e ciò che siamo è la nostra unica e vera ricchezza, che ciascuno per sé possiede.
Lo scetticismo, inoltre, è ciò che ci impedisce ogni riconciliazione con qualsiasi idea metafisica, legata al credere che possa esistere qualcosa di trascendente noi stessi e il trascorrere stesso della vita, insomma che al di là di tutto vi possa essere un qualcosa di fisso, di immobile e quindi di eterno, come pensano i preti di ogni confessione o coloritura politica, i quali sono le sanguisuga, i vampiri che succhiano la vita degli altri, come giustamente, a mio parere, sostiene F. Nietzsche.
Lo scetticismo, tuttavia, non va mai inteso come un punto d'arrivo, ma di partenza, nel dar corso ad una qualsiasi esperienza, in quanto la rende per noi stessi più critica e in questa misura anche più interessante, perché tutto inizia dall'aver eluso lo “scontato” in partenza, nel volervi dar corso. Ma non può essere assunto a regola fissa, dietro cui sguardare il mondo e ogni esperienza, perché un simile cipiglio critico, da un lato ci rifarebbe ricadere nella metafisica, da cui credevamo esserci liberati, proprio considerando immutabile questo stesso nostro punto di vista rispetto al succedersi di noi e del mondo, quindi sarebbe un punto di vista trascendentale; dall'altra, così guardando le cose, ci esporremmo ad un'illusione svantaggiosa per noi stessi, in quanto col credere in una sospensione del giudizio su tutto, finiremmo nell'incauta situazione di patire passivamente questo stesso tutto, che apparendoci inconsistente e indefinito nel forse di tutto, ci attraverserebbe senza che noi stessi, decidendo su nulla, ne rimarremmo coinvolti. Il nostro destino potrebbe in questo caso essere nostro, ma anche di un qualsiasi altro. Ed è qui che metteremmo in gioco la nostra effettiva libertà, dato che qui non sussisterebbe, in nessun caso, venendo meno ogni senso per agire in un modo o in un altro.
«La libertà – come scriveva Jaspers – si conosce non attraverso lo studio, ma attraverso l'azione». La mia libertà mi si rivela nella sua realtà, attraverso l'esperienza d'una decisione responsabile che io prendo su di me all'interno del mondo del quale faccio parte. Nel far questo non coinvolgo solo me, ma anche quest'ultimo, allo stesso modo che tutto ciò che vi accade incide su di me e sulle mie più proprie prospettive; per cui nulla di ciò che accade e mi accade intorno può essermi indifferente, nemmeno il volar di una foglia.
Ciò che io decido, nel deciderlo impegno me stesso totalmente, vale a dire ciò che io sono, e non in base ad una evidenza logica, ma a una evidenza esistenziale, in quanto si tratta di un'esperienza che intendo compiere e perché ad ogni problema puramente teorico sfugge che il tutto si possa risolvere tramite un'accurata e appropriata indagine di pensiero.
Ogni decisione che prendo non la ritengo mai un fatto, ma piuttosto una cosa da fare, che non va dunque presa come un'azione predeterminata, ma come un evento che mi sono impegnato ad attuare.
La mia capacità decisionale costituisce il fondamento stesso della mia reale libertà, in quanto su di essa io mi auto-determino nella mia particolare posizione, nell'ambito dei miei stessi rapporti intrattenuti con gli altri se stessi e con il mondo che mi circonda.
Il fatto che io mi scorga continuamente chiamato a decidere di me, quindi ad assumermi responsabilità, non evidenzia la mia libertà, quanto invece il luogo della mia necessità. La mia libertà risiede nella decisione stessa che prendo, in quanto è una radicale operazione di riduzione operata riguardo alle mie stesse possibilità. Perché decidendo opero una scelta ed è questa scelta a liberarmi dall'incombenza di poterne subire una qualsiasi delle altre, non scegliendo.
La libertà non risponde sullo spettro di tutte le mie possibilità teoriche, quanto invece esclusivamente sulla scelta operata su una di queste, e nel volerla realizzare si impedisce materialmente il realizzarsi di tutte le altre, che in qualche modo permangono irrealizzate, quindi impossibilitate ad esistere.
Ogni scelta è libertà che mi impegna, in quanto la mia libertà è la coscienza stessa del mio dominio, che si manifesta nello scegliere di realizzare questa cosa piuttosto che quest'altra. È in relazione alle mie stesse possibilità che io istituisco il mio dominio, operando una scelta, perché operandola escludo tutte le altre dal mio campo d'intervento materiale. Ogni scelta è, in questo senso, totale e mai parziale.
La libertà non è nell'azione, ma riposa nella decisione presa nel mio essere che l'ha costretta a manifestarsi in quel modo e non in un altro. Ed essa è sempre e comunque espressione di quello che io sono e nient'altro al di fuori di questo.
L'individuo, signore di tutte le cose e non sottomesso ad alcuno, si vuole non derivato da altro, ma esclusivamente da se stesso, e vive per se stesso e a misura di se stesso. Il suo aver coscienza del proprio dominio, o sfera della propria forza, è la coscienza stessa della propria reale libertà, in quanto, sua propria potenza, unico limite è se stesso. Il suo associarsi con gli altri individui, in ragione dell'accrescimento della propria potenza, diviene libertà in ciascuno, coestensiva a ciascuno.
Per quanto possa sembrare paradossale, l'individuo fattosi creatore dei propri valori è colui che è ora cosciente che la sola cosa che può affermarlo, o annientarlo, è la sua stessa forza, che ne costituisce l'essenza. La sua causa – come sostiene Max Stirner – l'ha riposta su nulla, a quel nulla a cui sa di dover ritornare realizzando se stesso.
Il nulla ci procura un'intima ripugnanza, in quanto costituisce il cessare stesso del nostro esistere; ed è la fonte di ogni più nostra angoscia e crisi, perché il sapere con se stessi che si è nulla, e che «tutto è nulla», annienta e distrugge sul nascere il nostro unico rimedio: le illusioni.
Il fallimento come esperienza di sé
Non è che nel durante della propria crisi esistenziale non si verifichi nulla, non accada nessun tipo di accadimento, al contrario in quel momento è in giuoco il tutto di noi stessi. Nel naufragio che l'attraversa da parte a parte, il nostro più proprio pericolo è quello di sprofondare nel mare delle circostanze, fino ad «uscire fuori di sé» in un indicibile dolore che porta allo «stupore» intravisto da Platone, come se avessimo finalmente ... finalmente trovato l' «ambiente adeguato», perché lì si cela il pericolo della perdita della nostra propria solitudine, essendo precipitati totalmente nella realtà.
Per non lasciarsi andare al proprio essere casualmente nel naufragio, cioè vivere senza lasciarsi disperdere nel divenire che tutto travolge, si ha bisogno in quel momento di decisione, che è lo slancio nell'affrontare i conflitti insorti tra l'Io e le circostanze della realtà dentro cui ci sbattiamo, rendendoci conto della situazione-limite che attraversa il nostro esistere, «messo a nudo» dalla crisi giunta al suo apice: la «nullità» di tutto. Ma non si può dire di aver mai pienamente vissuto, se non si è provato il sentimento della nullità di tutto – compresi se stessi.
L'uomo, insegna Heidegger – allineato alla più pura tradizione filosofica greca –, è colui che pone domande sull'essere, fino a spingersi nell'intimo di questo strano «essere», che per lui non solo esiste, ma è chiamato a farlo in senso proprio, nella sua condizione essenzialmente tragica, che è quella di spingere il pensiero stesso verso il suo stesso estremo limite, lì nel fondo da cui viene estratto: l'abisso del nulla, e in questa tragedia, come sapere della nullità di tutto compreso se stesso che genera angoscia, l'uomo non raccoglie la «speranza», ma unicamente la «decisione» di addossarsi il peso di ciò che questa angoscia gli procura. L'uomo nel durante del suo stesso esistere, si carica il proprio peso da sé sulle spalle, e questo peso è quello di essere se stesso come uomo, e non limitarsi semplicemente ad essere un qualsiasi uomo tra gli uomini.
Si vive finché si è disposti a conferire a se stessi «illusioni» e nel contempo si è ancora disposti, nonostante tutto, ad accettare il dolore che ci procura il farsi in noi di ogni esperienza come ineluttabile fallimento. La nostra volontà di esistere e di vivere, che non trova alcuna «giustificazione» al di fuori di quella che gli accordiamo noi stessi, ha un senso proprio in ciascuno proprio per questo. Nel piacere concretamente provato si cela sempre, implicitamente, il dispiacere contenuto nel nostro stesso desiderio, che permane in rapporto a se medesimo sempre infinitamente inappagato; ciò è la nostra forza d'illusione, che è sempre anch'essa infinitamente superiore alle nostre reali energie, che le spinge sempre al loro totale prosciugamento. L'insoddisfazione, che sempre permane in noi, è la fonte che alimenta il nostro infinito desiderio, vale a dire l'illusione o, se si preferisce, la «volontà di potenza».
La fine di ogni esperienza è del tutto simile alla morte degli altri; entrambe ci arrecano fastidio, perché è il nulla che ci si presenta nel venir meno in noi di un bene o di un'illusione cui prima avevamo accesso; è questo sentircene irrimediabilmente privati che ci addolora; quindi è il non poter disporre più della presenza delle stesse che ci affligge, perché ci davano piacere e in questa misura ci stavano veramente a cuore; al di fuori di questa condizione qualunque fosse stata la loro sorte, ci sarebbe stata indifferente, o meglio, del tutto estranea.
È solo a cose fatte che ognuno riconosce il fallimento della propria singolare esperienza compiuta; perché non ha potuto esimersi nell'averlo vissuto come perdita della sua presunzione sull'oggetto che gli era caro. In questo sono le sue più proprie illusioni, a cui mai più potrà tornare nell'identico modo. Ma è il fallimento a rivelargli ciò che di più proprio e di più particolare vi è in lui come differenza e unicità rispetto ad ogni altro se stesso, in quanto tutto ciò è la risultante della propria singolare esperienza vissuta.
La differenza e l'unicità di ciascuno non consistono mai nelle affermazioni operate a priori su di sé, quanto, invece, in quel «non sapersi», che nessuno ha mai supposto né mai sospettato lontanamente prima. Ciò lo scopre nel dopo di ogni esperienza compiuta, e i motivi del fallimento sono sempre ciò che si è, e nient'altro al di fuori di questo.
Ogni esperienza, venendo a costituire un particolare momento di quel divenire così come siamo, senza sosta, crea la nostra storia individuale. E questa è, prima di ogni altra cosa, storia di ciò che singolarmente abbiamo patito, come successione ininterrotta dei nostri più propri fallimenti. Se possiamo sostenere di possedere un'esperienza o una qualsiasi cosa, è perché in qualche momento della nostra vita l'abbiamo patita come nostro fallimento, così come si può dire che siamo disposti a farla, solo quando ci esponiamo nel compierla al rischio-condizione ineluttabile che questa sempre comporta: il fallimento. Perché se non fallissimo puntualmente, come del resto ci capita non ne avremmo nemmeno idea, in quanto permarremmo prigionieri di un sogno senza fine.
Se riconosciamo ciò che è nostro da ciò che non lo è, dipende esclusivamente da questo nostro puntuale fallire. Il nostro «Io» è reale, differente ed unico, in misura di tutto quanto si attiene proprio all'insieme dei nostri fallimenti; in quanto «lui» è tutto ciò da cui, in un modo o in un altro, è andato separandosi, vale a dire fallendosi, nei suoi tentativi di unione con l'altro polo della relazione, che costituisce assieme al suo sé la base di ogni esperienza. Nessuno può dire, o sostenere, che si può fare isolati da tutti un'esperienza, se non intenderla in senso mistico, ma allora è un'altra storia, si tratta di una ricerca legata alla fede.
L'esistenza è il «naufragio» del nostro esistere, che ci espone in modo assurdo e allucinante a un permanente fallimento, riscontrabile nel farsi in noi di ogni esperienza, ed è questa, a mio parere, la radicale condizione in cui versa, nel suo imprescindibile volersi, l'esistenza di ognuno. Finché si vive nessuno può assolutamente sottrarsi a questa condizione, significherebbe morire, proprio perché nella nostra concretezza quotidiana a sostenerci sono le nostre più proprie illusioni e a farci ricominciare dopo ogni fallimento sono proprio ancora ... ancora le nostre ineludibili illusioni, che divengono anch'esse uniche e irripetibili, in misura dei nostri stessi fallimenti patiti, in quanto le hanno costrette a modificarsi in ragione proprio di questo fallire. Più è stato grande il nostro fallimento, più grande ancora sarà la nostra voglia d'illusione, affinché tutto in noi riprenda il suo corso come prima. Se no ci si suicida, accettando così l'essere che vi è in noi, come pure in ogni cosa, come inconoscibile, vale a dire l'assoluto nulla, poiché esistere e vivere è illudersi sempre e comunque di non essere «nulla» e, ancora ..., ancora illudersi che si possa in qualche modo sfuggire alla morte verso cui irrimediabilmente e irreversibilmente stiamo andando incontro nel farci nel nostro tempo di giorno in giorno sempre più ciò che siamo.
L'Io e l'illusione
Da quanto ho sostenuto finora, se ne può trarre l'impressione che io consideri il problema esistenziale come una specie di caso isolato, quasi che ogni ricerca operata in questo senso prescindesse completamente in ognuno da quella dell'altro. A ben guardare, in effetti, è proprio così. Perché si tratta della ricerca in ognuno di ciò che è, escludendo il suo di fuori, per cui rientra, pur interessando tutti, esclusivamente nella dimensione soggettiva, che è propria a ciascuno di noi singolarmente considerato.
Riguardo alla propria esistenza ognuno di noi può dire e sostenere quel che vuole, unica cosa certa è che tutto, al di là di ogni giuoco più o meno interessante intrattenuto con la nostra breve vita, alla fine si risolverà tutto col nostro rientrare nel nulla da cui siamo sporti provvisoriamente, venendo al mondo in modo assolutamente, per noi stessi, non voluto, e di noi nel mondo non resterà che per un istante brevissimo uno «spazio vuoto», subito dopo colmato da una qualsiasi altra cosa. Prima e dopo di noi, per ciascuno di noi, vi è solo l'assoluto nulla, che non è l'altro nome di «Dio», ma l'assenza di sé come presenza di sé in relazione a questo tutto, quindi mancando se stessi manca per noi anche il tutto, quindi è il nulla, l'assoluto nulla. Nulla di noi sopravviverà a noi stessi e per noi stessi. Noi siamo, per noi, principio e fine di ogni cosa. Si è nati interamente e allo stesso modo si muore interamente. È a partire da questa considerazione della nullità di sé e di tutto, che nessuno può ritenere se stesso, finché esiste, un «nonnulla» o come uomo qualsiasi, ma esclusivamente un se stesso, ed è ciò e non altro a conferirgli un suo proprio unico e irriproducibile destino.
Io sono sempre Io, sia prima che dopo. Questo al di là di ogni ragionevole dubbio, o irragionevole certezza, che mi travaglia sul conseguimento di ciò che più mi sta a cuore, dell'incertezza e dell'indeterminazione, che come cifra di ignoto grava sul mio destino, e della disperazione legata a quelli che saranno o non saranno tutti i miei prossimi più propri fallimenti.
La mia irrisolutezza esistenziale mi è data esclusivamente da quello che «Io» stesso sono, che in me rimane disperatamente senza risposta, e non certo per quello che non riesco ad essere o quello che vorrei o dovrei essere; se lo fossi o lo diventassi avrei unicamente rinunciato a me stesso o evaso me stesso.
Per quanto tormentato, disperato, se ho scelto di essere me stesso, sostanzialmente io sono sempre quel che sono, in tutte le circostanze, belle o brutte, della mia vita. Perché mai dovrei dispiacermi di me, se sono io, assolutamente io, in tutto quel che faccio? Il mio destino è così irrimediabilmente segnato, in quanto è unicamente la «decisione» che io prendo su di me.
Perdere se stessi significa, per me, smarrire il luogo della propria solitudine, vale a dire precipitare totalmente nella realtà, non avendo più alcuna capacità di astrazione e quindi di immedesimazione su ciò che mi suggerisce la mia stessa immaginazione. Sarei, di fatto, precipitato in un sogno senza alcuna possibilità di potermi ancora donare illusioni. E la cosa più assurda è che non potrei, come possibilità, considerare nemmeno l'idea di suicidio, dal momento che tutte le mie possibilità mi sono date unicamente dalla mia coscienza, che è quel poter rilevare, in qualsiasi situazione, lo scarto che esiste tra me e la realtà che vivo. L'identificarsi con qualsiasi cosa è nient'altro che una perdita di coscienza, il voler stare nelle cose che più ci piacciano o l'inseguire la felicità, sottende sempre questa perdita. Si è felici senza coscienza, quando ci si rende conto di qualcosa è perché la si è perduta.
Chi insegue la felicità, sostanzialmente insegue la realizzazione della propria prigione senza saperlo, vale a dire insegue il sogno che lo porta all'incoscienza, al non sapersi di sé.
Solo cessando di esistere non si hanno materialmente più problemi, perché essi stessi sono delle nostre pure illusioni, che hanno il vantaggio, rispetto alle altre, di non lasciarsi mai risolvere, per cui bisogna pure tenerseli ben stretti se si vuole vivere e non semplicemente vegetare. La felicità non vale la più piccola delle insoddisfazioni.
Se dovessi riconoscere il vero nell'esistenza di tutto ciò che esiste, non mi rimarrebbe altra alternativa che suicidarmi, perché in questo senso è meglio non essere mai nati o affrettarsi ad uscire dal mondo il più presto possibile. Se non ci fosse l'illusione a sostenere la specie umana, questa sarebbe scomparsa da un pezzo.
Quel che di me posso dire è che riconosco la mia ombra, in ogni caso, finché esisto e vivo, sempre e comunque, sempre più reale di me, dato che a giustificarla sono io, con la mia presenza, ma per quanto mi concerne non ho alcuna spiegazione che possa in qualche modo logicamente giustificarmi. Per questo, volendo vivere vi provvedo io stesso con le mie ineliminabili illusioni.
L'Io? L'Io è l'illusione di esistere, che dentro di me giuoca a motivare tutte le altre. E a questo punto, chi può sostenere che l'illusione è nulla? L'illusione di non essere nulla è la mia illusione più grande: ESISTERE.
A mo’ di apertura
Va da sé, che quanto sostenuto in queste note è una mia personale interpretazione del problema esistenziale, e il suo significato è ben lungi dall'essere stato esaustivo. Ma questo non era neppure il mio intento, ciò che qui mi interessava era semplicemente aprirlo alla discussione, che mi auguro sia proficua in questa sede, anche se ognuno, ben inteso, i propri nodi esistenziali è chiamato a scioglierli da sé nel proprio quotidiano.
Pier Leone Porcu